La vaneddra non è la strada.
La strada col suo fascino maudit, la strada che conduce al di là di tutti gli orizzonti, ha sempre avuto i suoi poeti vagabondi, che l’hanno amata e cantata come strumento e simbolo della rivolta contro i valori del domicilio fisso. La vaneddra, invece, continuazione corale dello spazio domestico, non conduce in nessun posto che non sia legato al mondo che lasciamo a casa. Essa impone il rispetto della sua dimensione sotto pena di essere emarginati e segnati a dito in ogni ora della giornata: e, pertanto, all’anticonformista si rivela sicura scorciatoia verso la follia.
Nella vaneddra non c’è posto per l’individualismo, come non c’è posto per il segreto o per il privato: tutto deve essere notificato al vicino, questa ossessiva presenza moralizzatrice a cui è impossibile sfuggire perché “lu vicinu è serpenti, si nun ti vidi ti senti”, avverte il proverbio.
Ricordo la vecchia prostituta piena di rughe e di belletto, ormai in pensione, che agli occhi della vaneddra rappresentava una specie di scandalo vivente, non tanto per il suo passato, quanto per l’orgogliosa freddezza, che è la falsa superiorità degli emarginati, dietro cui nascondeva se stessa e la sua vita. E noi ragazzi, istintivi autentici figli della vaneddra, ne diventavamo l’inconsapevole braccio secolare quando ci divertivamo a tirare pietre contro la sua porta. E lei si precipitava fuori col manico della scopa levato in aria, mentre metteva a profitto il suo barocco e vasto repertorio di parolacce, applicandolo alle nostre madri e sorelle. Ma, pur essendo suscettibile come petardi, le donne interessate non si prendevano neanche la bega di inscenare una risposta a quelle parolacce, che diventavano piuttosto ulteriore motivo di celato riso a spese della sventurata, che nella solitudine derisa scontava il prezzo del suo individualismo.
La vaneddra conteneva l’anima del mondo contadino e nessun essere poteva condurvi un’esistenza individualmente autonoma dalle sue occulte determinazioni. Né bastava pensare di morire per credere di andarsene finalmente liberi, solitari vagabondi metafisici: perché neanche la morte veniva concepita come quell’esperienza irriducibilmente personale che è.
Quando morì il vecchio più vecchio di tutta la vaneddra (un arteriosclerotico che di notte sgridava i familiari che gli spegnevano la luce e di giorno voleva essere trattenuto per non tagliare la pergola che gli faceva ombra), il primo commento lo sentii da mia madre che, mentre si apprestava alla visita di rito, disse “ora devono morire altre due persone nella stessa vaneddra , perchè si deve formare la croce”.
 Dunque, era cosi: ogni volta che un uomo moriva, segnava il punto iniziale di una croce immaginaria i cui restanti punti si sarebbero topograficamente distribuiti nella vaneddra con altrettanti morti. La scoperta insinuò nel mio essere la superstiziosa necessità di completare la croce e mi fece sentire un punto potenziale di quella nascente costellazione di lutti. Intanto, la vaneddra era sprofondata in una tristezza che fermava il tempo, nessuno osava parlare a voce normale con i vicini, i ragazzi venivano ammoniti perché andassero a giocare lontano, i rumori del giorno si spegnevano, lasciando il silenzio al pianto intermittente dei parenti del morto. In quel disarmante microcosmo, io col mio muto terrore mi aggiravo formulando progetti di salvezza. Perché non andavamo ad abitare in un altro posto, prima che fosse troppo tardi ? Perché mio padre non vendeva la casa per salvare tutta la famiglia dalle reti parate dalla morte ?
Dunque, era cosi: ogni volta che un uomo moriva, segnava il punto iniziale di una croce immaginaria i cui restanti punti si sarebbero topograficamente distribuiti nella vaneddra con altrettanti morti. La scoperta insinuò nel mio essere la superstiziosa necessità di completare la croce e mi fece sentire un punto potenziale di quella nascente costellazione di lutti. Intanto, la vaneddra era sprofondata in una tristezza che fermava il tempo, nessuno osava parlare a voce normale con i vicini, i ragazzi venivano ammoniti perché andassero a giocare lontano, i rumori del giorno si spegnevano, lasciando il silenzio al pianto intermittente dei parenti del morto. In quel disarmante microcosmo, io col mio muto terrore mi aggiravo formulando progetti di salvezza. Perché non andavamo ad abitare in un altro posto, prima che fosse troppo tardi ? Perché mio padre non vendeva la casa per salvare tutta la famiglia dalle reti parate dalla morte ?
Soltanto adesso, decifrando retrospettivamente la simbologia delle morti che dovevano disporsi a croce tra le abitazioni della stessa vaneddra, indovino tutta l’importanza che quella cultura attribuiva alla topografia fisica dell’esistenza, e mi rendo conto che la vaneddra univa i propri abitanti in un vincolo di parentela territoriale che neanche la morte riusciva a dissolvere.
Allora ero teso in una sola preoccupazione: salvarmi, vivere il più a lungo possibile, all’infinito. Forse la cosa più terribile che accade all’uomo nell’infanzia è scoprire la cognizione della morte come distanza dal mondo, privazione delle sue cose, delle sue forme, dei suoi colori. Poi, si intuisce che vivere significa spingersi continuamente verso qualcuno o qualcosa e ci si spinge verso la madre, verso un albero o verso una montagna che ci salva, ma nel contempo ci imprigiona per sempre dentro la sua immagine.
Restare solo, per me, significava arrivare a due passi dalla morte, mentre la vaneddra era il luogo dell’impossibile solitudine e mi si offriva come la guida più certa per andare in direzione opposta a tutti i pensieri carichi di tristezza: perciò divenne la mia passione incorreggibile. Ancora sento la voce di mia madre che sull’uscio di casa mi sgridava “vaniddraru, torna dentro”, oppure “la vaneddra ti chiama”. Aveva ragione, ma non sapeva che il suo rimprovero era il vangelo capovolto della mia salvezza.
L’importante era stare all’aperto assieme agli altri, e poco o nulla contava che l’occasione fosse data dalla recita del rosario nelle sere estive o dal sadico inseguimento dei cani randagi in amore.
La recita del rosario di uomini e donne seduti in semicerchio davanti agli usci o sulle scale esterne delle case era l’espressione più consueta dell’identità corale della vaneddra. Ci si accomodava ( noi ragazzi sulla nuda terra, quando non fruivamo del lusso di qualche sacco di iuta ) e, prima di cominciare, nell’attesa che arrivassero i ritardatari, si faceva una specie di diario collettivo, dove ognuno raccontava le cose “straordinarie” capitategli durante la giornata. E là nessuno si azzardava a spingersi tra le malevolenze dello sparlittìo, perché si era in numero compromettente per simili piaceri e, soprattutto, perché le pie intenzioni che motivavano la riunione, col loro riflesso di sanzione soprannaturale, rendevano gli animi buoni e santi, come durante i temporali di biblica violenza, quando le madri di famiglia stendevano la figliolanza sul letto grande.
Aggregando la mia voce al coro lamentoso, ripetevo “ Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori…”, ma era un puro automatismo labiale, dietro il quale, di vero c’era soltanto l’ansia di arrivare alla fine della litania, perché, allora, gli anziani si sarebbero messi a rievocare i fatti e gli uomini del tempo antico.
 Più che un concetto temporale, il “tempo antico” era per un luccicante universo formato dalla successione di quei fenomeni che io avrei voluto vedere di persona: apparizioni luminose, incontri con animali sconosciuti, marenghi d’oro che piovevano dalle crepe di un muro, genitori defunti che si recavano dai figli per avvertirli di qualche pericolo imminente. I vecchi parlavano di quegli eventi come se dicessero della pioggia o delle bestie: sapevano renderli concretamente familiari con l’abitudine che avevano di legarli in un modo o nell’altro alla vaneddra. “Vedete la casa dove ora sta Michele” cominciavano “ là, un tempo abitava la buonanima di Filippo Scimè”, e, dopo questo regolare preambolo, si snodava il fatto che perpetuava il nome di Scimè nella memoria dei suoi posteri e nell’aria calda della sera impregnata di sentori di stalla e di basilico.
Più che un concetto temporale, il “tempo antico” era per un luccicante universo formato dalla successione di quei fenomeni che io avrei voluto vedere di persona: apparizioni luminose, incontri con animali sconosciuti, marenghi d’oro che piovevano dalle crepe di un muro, genitori defunti che si recavano dai figli per avvertirli di qualche pericolo imminente. I vecchi parlavano di quegli eventi come se dicessero della pioggia o delle bestie: sapevano renderli concretamente familiari con l’abitudine che avevano di legarli in un modo o nell’altro alla vaneddra. “Vedete la casa dove ora sta Michele” cominciavano “ là, un tempo abitava la buonanima di Filippo Scimè”, e, dopo questo regolare preambolo, si snodava il fatto che perpetuava il nome di Scimè nella memoria dei suoi posteri e nell’aria calda della sera impregnata di sentori di stalla e di basilico.
Fu in una di quelle serate che venni a sapere perché il cortile in fondo alla vaneddra era noto come “lu curtigliu di la dannata”. Dal suo interno, per una scala di gesso muschioso, si accedeva a una camera che, a sua volta si affacciava sulla vaneddra con un angusto balconcino così traboccante di garofani che faceva paura passarci sotto, perché pareva sul punto di cedere all’eccessivo peso.
 Chissà quanto tempo addietro, in quella camera aveva vissuto una donna che si chiamava Marianna Zucchetto. Il marito era emigrato in America con la solita speranza dei poveri, che è quella di tornare tanto ricchi da comprarsi una chiusa di terreno. E intanto mandava soldi a lei, alla moglie che, invece di custodirli, li andava scialando con un prete. Quando, dopo dodici anni, rientrò dall’America, trovò la porta chiusa. Bussò, chiese della moglie ai vicini, attese, finché con una scala a pioli salì sul balconcino ed entrò in casa: trovò la moglie impiccata alla trave del tetto e una lettera sul tavolo scritta da lei prima di morire, per spiegargli che di tutto il denaro inviatole in quegli anni non restava neanche un soldo. Diceva che i suoi peccati non ammettevano perdono e lapidariamente chiudeva la lettera così: “ Entra all’inferno Zucchetto Marianna”
Chissà quanto tempo addietro, in quella camera aveva vissuto una donna che si chiamava Marianna Zucchetto. Il marito era emigrato in America con la solita speranza dei poveri, che è quella di tornare tanto ricchi da comprarsi una chiusa di terreno. E intanto mandava soldi a lei, alla moglie che, invece di custodirli, li andava scialando con un prete. Quando, dopo dodici anni, rientrò dall’America, trovò la porta chiusa. Bussò, chiese della moglie ai vicini, attese, finché con una scala a pioli salì sul balconcino ed entrò in casa: trovò la moglie impiccata alla trave del tetto e una lettera sul tavolo scritta da lei prima di morire, per spiegargli che di tutto il denaro inviatole in quegli anni non restava neanche un soldo. Diceva che i suoi peccati non ammettevano perdono e lapidariamente chiudeva la lettera così: “ Entra all’inferno Zucchetto Marianna”
“La disgraziata era istruita”, diceva mia nonna materna, che l’aveva conosciuta, intendendo “disgraziata” per moralmente laida, e “istruita” come attributo demoniaco. E la sua opinione era l’unanime opinione della vaneddra, che non sapeva ricordare il nome di Marianna, se non chiuso in quella sua ultima frase, che in realtà nascondeva un desiderio di espiazione così grande da accecare ogni istinto di salvezza. Ma in quel mondo esistevano peccati o trasgressioni che la stessa eternità non era sufficiente a cancellare: una donna che “sbagliava” comprometteva per più generazioni le donne di tutta la famiglia. Di quella logica tribale Marianna era stata martire paradossale e misconosciuta, giacché, incapace di essere all’altezza del suo peccato fino alla fine, l’aveva ferocemente riconfermata nel suo gesto autopunitivo.
 Miluzza, invece, era sta sul punto di esserne la vittima. La ricordo, intravista attraverso la porta semichiusa, china sulla bocca del focolare intenta a soffiare sulla legna che prendeva tempo ad accendersi. Pur avendo superato l’età da marito, viveva ancora nella casa natale con i genitori. Da certi discorsi, fatti sottovoce in luoghi ritirati dagli adulti, avevo raccolto che il suo zitellaggio era dovuto a mancanza di partiti. “Per colpa di quella sporcata”, sentivo dire, con allusione a una sua zia che, metaforicamente parlando, aveva preparato il caffé a un tale malandrino, che, a cose fatte,si era assunto l’impegno di imporre al marito cornificato silenzio e rispetto per la moglie cornificatrice. Ora, tutti erano concordi nel riconoscere in Miluzza una ragazza d’oro, “ ma intanto, ognuno… Dio ce ne scansi e liberi”, cioè dall’andare a cadere in mezzo alle corna.
Miluzza, invece, era sta sul punto di esserne la vittima. La ricordo, intravista attraverso la porta semichiusa, china sulla bocca del focolare intenta a soffiare sulla legna che prendeva tempo ad accendersi. Pur avendo superato l’età da marito, viveva ancora nella casa natale con i genitori. Da certi discorsi, fatti sottovoce in luoghi ritirati dagli adulti, avevo raccolto che il suo zitellaggio era dovuto a mancanza di partiti. “Per colpa di quella sporcata”, sentivo dire, con allusione a una sua zia che, metaforicamente parlando, aveva preparato il caffé a un tale malandrino, che, a cose fatte,si era assunto l’impegno di imporre al marito cornificato silenzio e rispetto per la moglie cornificatrice. Ora, tutti erano concordi nel riconoscere in Miluzza una ragazza d’oro, “ ma intanto, ognuno… Dio ce ne scansi e liberi”, cioè dall’andare a cadere in mezzo alle corna.
Ma poiché non resta grano a mietere né femmine a maritare, dice un proverbio, anche per Miluzza arrivò il giorno in cui cessò di sospirare, illanguidendo dietro l’uscio, a spiare i giovanottoni che passavano, ora a piedi incravattati, ora sui muli in tenuta di campagna. Una mattina di buonora la madre di Miluzza si fece il giro dei vicini porta per porta: “Abbiamo Miluzza zita”. “Con chi ?” “ Con un borgese ricco di Campobello”.
“Prosita ! Cu si marita nni la so vaneddra bivi nni lu bicchieri”, chi si sposa nella sua vaneddra beve nel bicchiere, si era complimentato una volta mio padre con un giovane che stava per sposare la sua vicina; e bere nel bicchiere significava non solo accostare, lui solo, le labbra all’orlo del bicchiere, ma anche vedere con i propri occhi la cristallina qualità dell’acqua. Appena intesi che il fidanzato di Miluzza veniva addirittura da un paese vicino, non potei fare a ameno di ricordarmi del bicchiere. Dove beveva questo campobellese ? E ragionavo: se la propria vaneddra è il bicchiere, il proprio quartiere sarà la bottiglia, il proprio paese la quartara, un altro paese sarà la pompa o l’abbeveratoio.
E tutto questo, mi dicevo, sol perché una zia di Miluzza se l’era intesa con un malandrino. Ma per l’appunto che quello era un malandrino, che colpa ne poteva avere la scintina? Come si fa a sottrarsi ai capricci di uno che non sai come la pensa?
Ma l’anima della vaneddra non condivideva quei dubbi e quei pensieri; e tanto meno le donne, i cui discorsi, che si scambiavano tra loro sugli usci delle case, costituivano la fonte autentica e permanente delle informazioni da cui si lievitavano i miei ragionamenti.
“La porta di rapi sempri di la banna d’intra”, la porta s’apre sempre dall’interno, argomentavano per significare che nei rapporti clandestini la colpa decisiva è sempre della donna. “ L’uomo può bussare quanto vuole, se la donna non gli apre dal di dentro…” Chiuse nella passiva accettazione di una condizione le cui radici si perdevano nel tempo, non avevano ancora scoperto l’inferno o la magia che fa del mondo un fluido concetto da plasmare a somiglianza dei propri desideri. Con quella spicciola metafora della porta che si apre solo da di dentro perpetuavano ancora il mito della mela e del serpente, ma soprattutto, e specialmente per quello che per me contava, lasciavano il malandrino seduttore indenne da ogni responsabilità per l’accaduto.
Nessuno osava disapprovare quello che un malandrino combinava. Lo si accettava con la sorda rassegnazione con cui si guarda a una calamità della natura o si soppesa la disgrazia nella trama di un destino. E questo mi fu chiaro in tutta la sua agghiacciante evidenza quando spararono a Caliddru lu crapraru.
Caliddru, per via delle capre che teneva in una delle tante stalle insinuate tra le abitazioni, era una presenza animatrice e familiare nella vaneddra. Si alzava la mattina presto come tutti gli altri uomini, ma non partiva come quelli con asini con muli e con giumente e con cani e con carretti alla volta delle contrade che circondavano il paese. Lui restava, e cominciava la sua giornata col pulire la stalla sotto la fioca luce di una lampadina intorbidita dallo strato puntiforme lasciato dalla mosche. Poi mungeva le capre, e, quindi, con un bidone bianco di alluminio e le misure, andava a distribuire il latte bussando alle porte del quartiere ancora mezzo addormentato. Nella tarda mattinata spingeva il piccolo gregge fuori paese, verso la campagna a pascolare.
Caliddru era giovane, allegro, parlava con tutti. Non incontrava persona a cui non avesse una frase scherzosa da dedicare o un saluto caloroso da rivolgere. Alle capre aveva dato nomi di donne, c’erano Maricchia, Caluzzeddra, Mariannina, Maddalena e noi ragazzi, quando attraversavano la vaneddra empiendola di lezzo e cospargendola di ceci neri, ci divertivamo a riconoscerle e a chiamarle con quei nomi; mentre le massaie, dal canto loro, col manico della scopa si adoperavano a farle transitare il più lontano possibile dagli usci.
 Con le belle giornate in primavera ci recavamo sulla cima di una collinetta , a ridosso delle ultime case del paese, ad avviare gli aquiloni. Spesso lì vicino trovavamo Caliddru che pasceva le sue capre, e certe volte, mentre le bestie se ne stavano tranquille a brucare l’erba d’orzo o a riposare, lui si univa a noi e con la sua destrezza di adulto ci aiutava a manovrare il filo per far prendere quota all’ aquilone.
Con le belle giornate in primavera ci recavamo sulla cima di una collinetta , a ridosso delle ultime case del paese, ad avviare gli aquiloni. Spesso lì vicino trovavamo Caliddru che pasceva le sue capre, e certe volte, mentre le bestie se ne stavano tranquille a brucare l’erba d’orzo o a riposare, lui si univa a noi e con la sua destrezza di adulto ci aiutava a manovrare il filo per far prendere quota all’ aquilone.
Caliddru fu trovato morto sulla strada dietro il camposanto, all’alba di un giorno d’inizio primavera. I contadini che andavano a zappare furono i primi a imbattersi nel suo corpo senza vita riverso sulla polvere e sul sangue.
Ricordo che quel giorno coincise con la mia prima gita scolastica e, già all’ora in cui mi avviai a scuola per la partenza, nella vaneddra non si parlava d’altro. Le donne nella penombra dei dammusi a bassa voce si aggiornavano tra loro sui dettagli del fatto, da quando s’era udito il pianto urlato della zà Vicenza, la vecchia madre che appena avvertita s’era precipitata verso il luogo del rinvenimento, tenuta a braccetto da due parenti che cercavano con forza e con parole di contenerne la convulsa agitazione.
Arrivai a scuola. Gli autobus erano lì, davanti al portone pronti ad accogliere i gitanti. Partimmo e fu una giornata di scoperte. Vidi il mare per la prima volta, la valle dei templi, la chiesa di san Nicola, la Cattedrale…Ascoltavo quanto ci veniva spiegato dagli insegnanti, ma il pensiero di Caliddru morto ammazzato si posava come un’ombra luttuosa sulle nozioni di storia e sul paesaggio, imponendosi comunque come l’evento più importante di quel giorno. “Vedete com’è bella la nostra terra, vedete quanti popoli ce l’hanno invidiata e contesa” ci ripeteva, intanto, con zelo pedagogico uno dei maestri più bravi e intraprendenti nell’assumere il ruolo di guida turistica.
L’indomani la maestra tra i compiti per casa ci assegnò una relazione su “Scoperte e impressioni di una gita scolastica”. Il mio componimento risultò il migliore e lo lesse alla classe, facendo notare come mi fossi soffermato a parlare di tutti i luoghi e i monumenti visitati, al contrario degli altri elaborati che ne consideravano solo alcuni. “Dove eravate voi con la testa, mentre il vostro compagno stava attendo a tutto?” Quell’elogio inaspettato mi sorprese. Tanto più che ricordavo di non essere stato poi così attento come diceva la maestra. E avrei quasi voluto confessarlo. Dire in classe che per tutto il tempo di quel giorno avevo pensato alla morte del mio vicino capraio. Alla morte di Caliddru, che non avrei più visto.
Non si seppe mai da chi e perché Caliddru fu ammazzato, anche se nella vaneddra si lasciava capire che quell’omicidio era affare di malandrini. Verità che tutti dovevano sapere e nessuno doveva dire. Nei giorni che seguirono l’assassinio, ogni volta che sentivo qualcuno fargli allusione o comunque parlarne in qualche modo ne registravo le parole con insospettato batticuore e poi per conto mio ci ragionavo sopra e costruivo la mia segreta concezione del mondo. “Certo” dicevano taluni ” non si ammazza un cristiano per niente: se gli hanno sparato vuol dire che qualcosa aveva fatto”. Questa specie di lapidario commento a quella morte che non aveva niente di cristiano, lentamente sedimentava nel mio spirito, e a tratti si imponeva con una forza ipnotica che paralizzava ogni facoltà di sentimento e di pensiero per lasciare pieno campo a una sorta di terrore silenzioso.
“Ecco “ pensavo “è come la zia di Miluzza: i malandrini hanno sempre ragione e il torto è sempre degli altri. Possibile che fanno solo male e non sono mai colpevoli di niente?” Questa constatazione me li faceva detestare ancora di più, anche se non ne conoscevo neanche uno. Se mi azzardavo a chiedere chi fossero costoro, venivo severamente zittito col preoccupato ammonimento che quelle erano cose che non mi riguardavano, che dovevo pensare a farmi i fatti miei… Ma dove sentivo certi discorsi? Anche il nonno, sebbene mantenendo inalterata la considerazione che mi usava nel parlarmi, un giorno mi aveva risposto “Ma tu, gioia, non hai bisogno di sapere chi sono i malandrini” “Perché?” “Perché i malandrini sono persone che è meglio non conoscere.”
Le sole voci discordi in quel coro di silenzi che si addensava sulla compagine del malandrinato erano quelle dei comunisti. La loro franchezza di linguaggio, non intervallata da improvvisi abbassamenti di tono nei discorsi, sembrava venir fuori da un’anima spartana e non adusa a mettere in conto la morte e la paura.
 Così erano Micalangilu e Maruzza, marito e moglie, a ragione, ritenuti accaniti comunisti. Abitavano in una delle case più povere di tutta la vaneddra: un vano a pianterreno, senz’altra apertura che l’ingresso e la cui cupa atmosfera di tugurio non riusciva ad essere lenita dall’amore che Maruzza vi profondeva col tenere sempre pulito il pavimento di creta e in bell’ordine l’arredo, miserabile e limitato appena all’essenziale: un letto, un tavolo addossato al muro, un comò, poche sedie. “Noi non siamo malandrini e manco ci scantiamo dei malandrini” “Noi siamo malandrini solamente con il pane e il coltello lo usiamo solo per tagliarlo” queste e simili frasi sentivo pronunciare a Maruzza, quasi con tono di proclama, nel conversare con le altre donne del vicinato. E mi accorgevo che quando la metteva in politica con lastime e corna sui proprietari caini e sui capitalisti sanguisughe, proprio perché comunista, non veniva presa sul serio. Mia madre alle sue spalle non poteva trattenersi dal ripetere e commentare ironicamente le parole intese da lei poco prima. “Certo, malandrini solo col pane! Però suo marito il giorno dorme e la notte veglia.” Alludendo non tanto alle dormite diurne di Micalangilu, che in verità andava a sgobbare a giornata per poche centinaia di lire, quando alle sue frequenti scorrerie notturne nelle campagne, dove, si diceva, andasse rubando frutta spighe olive mandorle e quant’altro necessario per campare.
Così erano Micalangilu e Maruzza, marito e moglie, a ragione, ritenuti accaniti comunisti. Abitavano in una delle case più povere di tutta la vaneddra: un vano a pianterreno, senz’altra apertura che l’ingresso e la cui cupa atmosfera di tugurio non riusciva ad essere lenita dall’amore che Maruzza vi profondeva col tenere sempre pulito il pavimento di creta e in bell’ordine l’arredo, miserabile e limitato appena all’essenziale: un letto, un tavolo addossato al muro, un comò, poche sedie. “Noi non siamo malandrini e manco ci scantiamo dei malandrini” “Noi siamo malandrini solamente con il pane e il coltello lo usiamo solo per tagliarlo” queste e simili frasi sentivo pronunciare a Maruzza, quasi con tono di proclama, nel conversare con le altre donne del vicinato. E mi accorgevo che quando la metteva in politica con lastime e corna sui proprietari caini e sui capitalisti sanguisughe, proprio perché comunista, non veniva presa sul serio. Mia madre alle sue spalle non poteva trattenersi dal ripetere e commentare ironicamente le parole intese da lei poco prima. “Certo, malandrini solo col pane! Però suo marito il giorno dorme e la notte veglia.” Alludendo non tanto alle dormite diurne di Micalangilu, che in verità andava a sgobbare a giornata per poche centinaia di lire, quando alle sue frequenti scorrerie notturne nelle campagne, dove, si diceva, andasse rubando frutta spighe olive mandorle e quant’altro necessario per campare.
Di Micalangilu mio padre raccontava che una volta, dovendo tenere a battesimo il primogenito d’un suo compare, l’arciprete, sapendo della sua fede comunista, se l’era chiamato in disparte facendogli presente che per fare da padrino bisognava essere cattolici. “Ma tu, sei cattolico?” E lui, mezzo risentito del dubbio sollevato, aveva risposto affermativamente esclamando “Porca l’ostia, se sono cattolico!”
Se sui malandrini in casa non mi si permetteva di porre domande, sui comunisti, viceversa, appena affiorava un accenno di curiosità veniva prontamente travolto da profluvi di risposte, chiarimenti, spiegazioni, consigli, ammonimenti e perfino profezie, specialmente da mia nonna, che di tempo in famiglia ne aveva più di tutti e lo trascorreva in gran parte nella sua stanza assorta a bisbigliare avemarie e padrenostri. Da lei avevo appreso che bisognava vigilare e pregare la Madonna della Catena per scongiurare l’arrivo dalla Russia di orde di comunisti pronti ad entrare a cavallo dentro il Vaticano, a trasformare le chiese in sale da ballo e a mandare i sacerdoti a zappare.
Le informazioni che mi venivano date talvolta mi turbavano per giorni e non perché temessi le crudeltà a cui si sarebbero lasciati andare i comunisti una volta al potere, come diceva mia nonna, ma perché restavo ugualmente affascinato dai comizi che venivano a fare nel quartiere. Mi rallegravano le bandiere rosse che rompevano il grigiore e la monotonia di tutti i giorni e soprattutto mi si riempiva il petto d’emozione a sentire le note di Bandiera Rossa che dagli altoparlanti a tutto volume inondavano la vaneddra. L’insanabile contrasto tra la dottrina di mia nonna e la simpatia per i comunisti mi impensieriva; ma col tempo credetti di sciogliere il dilemma pregando segretamente in chiesa per la loro conversione. Tanto più che me li sentivo alleati nella insofferenza per i malandrini e per tutto quel misterioso silenzio che proteggeva le loro malefatte. Un giorno, in campagna elettorale, passarono distribuendo dei volantini su cui c’era scritto LA D.C. PARTITO DELLA MAFIA. Corsi nella stanza di mia nonna: “Ecco il partito che tu difendi.” Babbu!” mi apostrofò. “Questa è tutta propaganda che vanno facendo per imbrogliare la gente”.
Dell’odio per il clero e del modo tutto loro che i comunisti avevano d’intendere la figura di Gesù Cristo ne avevo riscontro nei discorsi che faceva Firrigno, il venditore di limoni poeta che di tanto in tanto spuntava nella vaneddra spingendo una carriola piena della sua unica mercanzia, con sopra adagiata una bilancia di rame. “Lumie, chi vuole lumie” gridava con voce stridula e priva di vigore. Era un uomo sui cinquant’anni, un po’ gracile e bassino; qualcuno diceva fosse malato da una vita. Prima faceva il fruttivendolo con mulo e carretto, portava per i quartieri del paese tanti tipi di frutta. Poi, volendo migliorare la propria condizione, assieme ad altri aveva deciso di partire clandestino per la Francia e così aveva venduto mulo e carretto. Ma alla frontiera era stato scoperto, arrestato e rimpatriato. Ritornato in paese, e sfumati nell’infelice avventura i soldi della vendita del mulo e del carretto, si era messo a fare il fruttivendolo con la carriola.
Quando lo sentivamo arrivare col suo inconfondibile grido, noi ragazzi gli andavamo incontro, e sciamandogli intorno lo sollecitavamo: “Zi’ Firrì, una poesia.” “Andate a giocare, oggi non ce n’è poesie”, ci licenziava mentre attendeva clienti . Ma dopo aver servito qualche donna che veniva a comprare le sue lumie sempre tirando sul prezzo e sempre trovando da ridire sul peso, cacciava fuori trinciato forte e cartine, si arrotolava una sigaretta e quando meno ce lo aspettavamo attaccava:
Cristo girava per la propaganda
dopo d’aver creata la natura
i preti riunirono una banda
e loro gli hanno fatta la congiura.
”Mandiamo a morte costui che comanda,
che non porta l’eguaglianza addirittura.”
L’hanno condotto sulla croce santa
dove gli hanno fatto la tortura.
A causa del suo intrattenerci non solo con le poesie ma anche con discorsi in cui facevano bella mostra di sé parole come progresso uguaglianza giustizia, Firrigno non era ben visto da quelle madri che non condividevano il suo anticlericalismo e prevedevano che morendo se ne sarebbe andato all’inferno con tutte le scarpe, cioè così com’era, senza salvare nulla , come chi si mette a letto senza togliersi neanche le scarpe. E siccome era così abile nei ragionamenti che ad attaccar briga con lui su Dio e sui preti si usciva sempre soccombenti sotto l’incalzare calmo e divertito dei suoi esempi azzeccati e delle sue frasi incisive, allora si diceva che ne sapeva più del diavolo e “Quando passa di qua cerca di non dargli conto” mi ammoniva mia madre. Mio padre, invece, con quel suo solito pragmatismo sbrigativo, diceva che il diavolo era troppo serio per essere compagno di Firrigno, che Firrigno era un asino, un asino che non aveva saputo sfruttare la sua intelligenza, lasciando così capire come per lui non mettere a materiale profitto l’intelligenza era un grave peccato di stupidità. E tirava fuori i nomi di tanti ex morti di fame, che con meno istruzione di Firrigno, però stando dalla parte giusta, nella Democrazia Cristiana, erano riusciti a ottenere un posto dal quale ora magari facevano soperchierie agli altri.
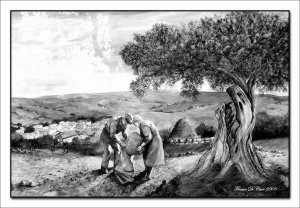 Il posto, di preferenza pubblico, stava in cima alle aspirazioni di quanti lavoravano in campagna. Era l’abracadabra che faceva sognare con la sua promessa di redenzione dallo stare esposti al sole cocente dell’estate o al ventoneve di lunghi inverni. Nel suo magico concetto si focalizzavano le tre condizioni di una vita senza pensieri: stare al riparo sotto le tegole, non alzarsi presto la mattina e aver certezza di stipendio a fine mese. Chi riusciva a realizzare quel sogno, elementare e straordinario nel contempo, saliva subito nella considerazione di tutta la vaneddra. Vicio Calì inteso Brillantina c’era riuscito. Aveva fatto propaganda nella squadra elettorale di un onorevole democristiano, che ad elezione avvenuta l’aveva sistemato in un ufficio dove non si sapeva o non si capiva cosa facesse di preciso, ma se la passava da dio. Quando parlava del suo nuovo stato stendeva le palme delle mani mostrando come fossero ormai scomparsi i segni deturpanti delle fatiche agricole. E con occhi luccicanti di gioia furbastra profferiva la fatidica frase “Nenti fazzu”, niente faccio, come prova incontrovertibile della sua fortuna, ma soprattutto come suggello della sua abilità di uomo che sa come va preso il mondo.
Il posto, di preferenza pubblico, stava in cima alle aspirazioni di quanti lavoravano in campagna. Era l’abracadabra che faceva sognare con la sua promessa di redenzione dallo stare esposti al sole cocente dell’estate o al ventoneve di lunghi inverni. Nel suo magico concetto si focalizzavano le tre condizioni di una vita senza pensieri: stare al riparo sotto le tegole, non alzarsi presto la mattina e aver certezza di stipendio a fine mese. Chi riusciva a realizzare quel sogno, elementare e straordinario nel contempo, saliva subito nella considerazione di tutta la vaneddra. Vicio Calì inteso Brillantina c’era riuscito. Aveva fatto propaganda nella squadra elettorale di un onorevole democristiano, che ad elezione avvenuta l’aveva sistemato in un ufficio dove non si sapeva o non si capiva cosa facesse di preciso, ma se la passava da dio. Quando parlava del suo nuovo stato stendeva le palme delle mani mostrando come fossero ormai scomparsi i segni deturpanti delle fatiche agricole. E con occhi luccicanti di gioia furbastra profferiva la fatidica frase “Nenti fazzu”, niente faccio, come prova incontrovertibile della sua fortuna, ma soprattutto come suggello della sua abilità di uomo che sa come va preso il mondo.
Quello che Brillantina esprimeva era la verità profonda di tutta la vaneddra. Il possedere pochi tumoli di terra, pur non liberando da una blanda povertà che non faceva morire di fame ma neanche vivere comodi, era alla radice di un orgoglio tanto tenace quanto immotivato. La terra aveva un effetto omeopatico nella testa di chi la possedeva. Ne bastava poca per infondergli atteggiamenti e comportamenti che nell’immaginario contadino erano legati allo status del proprietario terriero : vantarsi di non dipendere da nessuno, andare ripetendo che ringraziando a Dio si stava bene, sentirsi rincuorati da un segreto disprezzo nei confronti di chi “la terra lu ittà e lu celu l’arriparà”, la terra lo ha gettato e il cielo l’ha riparato, cioè di chi era nato privo di risorse. Ed essere riparati dal cielo , sotto l’evidente ironia della parola, significava trovarsi in balia delle intemperie della natura e della storia.
Nel posto pubblico c’era il vantaggio di non avere a che fare con un padrone in carne e ossa e questo accendeva fierezza e vanto di non fare niente percependo ugualmente lo stipendio. Lavorare “sutta d’antru”, sotto l’altrui comando,invece, implicava un greve marchio di servilismo che toglieva prestigio e dignità. E se le circostanze della vita lo rendevano proprio necessario, allora il concetto veniva chiosato da opportune precisazioni, addolcito con descrizioni di un rapporto confidenziale e quasi paritario col padrone. Quando l’emigrazione all’estero raggiunse tutto il mondo contadino risucchiando anche figli di burgisi (coltivatori diretti ritenuti benestanti), sollecitò quel modo di pensare rendendolo fecondo di tutta un’aneddotica che a ricordarla adesso mi appare surreale e penosa.
da www.solfano.it


